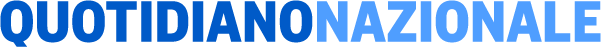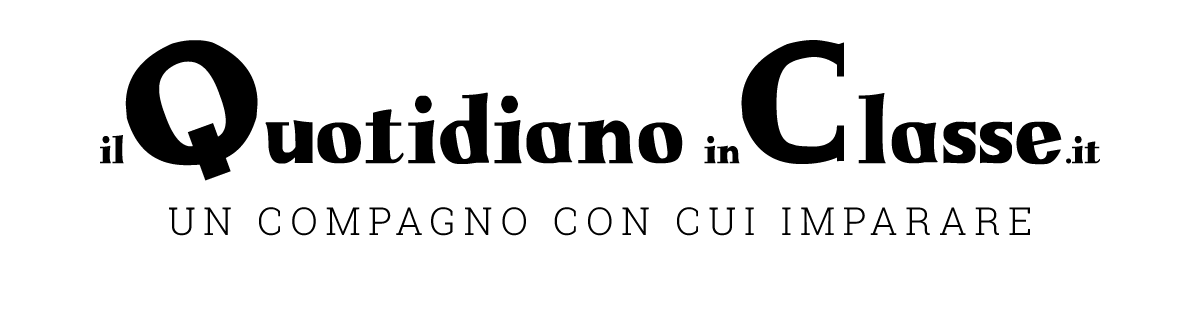Se Cosimo di Rondò, barone rampante, dopo esser salito sugli alberi di Ombrosa come imperituro atto di ribellione, non avesse iniziato a organizzare comitati cittadini per spegnere gli incendi, fronteggiare i lupi, aiutare contadini e ladri di frutta, ma al contrario si fosse rifugiato in su fra i rami come un esule, tanto lontano da non vedere i diti puntatigli contro e udirne i giudizi, allora sarebbe divenuto un hikikomori.
Proprio come Cosimo, gli hikikomori cercano un modo nuovo di intendere il mondo, una pausa rivoluzionaria in cui possano stabilirsi, rifugiarsi dai flutti del fuori o dalle sue incomprensioni: la più grande differenza fra Cosimo e gli hikikomori è però che, mentre Cosimo trova un disimpegno che si rivela essere fervido impegno intellettuale e sociale, gli hikikomori si rifugiano innocui nel loro castello di carte, e lì restano.
E se Cosimo, che dopo essersi rifugiato sugli alberi come atto di desatellizzazione da una famiglia che è tutta una rigida nobiltà in decadenza, si rituffa nell’eterogeneo mare del vivere, gli hikikomori sono costretti a prendere la via degli alberi per una commistione di motivi profondissimi, cronici, tipici della nostra età e che non lasciano loro che sviluppare un trauma insanabile per tutto quello che è fuori.
Gli hikikomori non sono semplicemente dei casi isolati di esuli, delle falle nel sistema più alto, geometrico e rigoroso: gli hikikomori sono lo spettro di tutti i noi; e i motivi che li hanno costretti ad isolarsi sono quei problemi che ammorbano il nostro stesso tempo, e la cui vicinanza, se non ci spinge sul nostro albero, tutt’al più ci intossica come una lastra in amianto.
La storia degli hikikomori è una storia dunque certo sociale, composita di precise dinamiche, come il bullismo, le gravose aspettative lavorative, sociali, di genere – il 90% degli hikikomori è uomo -, i contrasti famigliari, i disturbi alimentari, l’illusione di un Internet propaggine delle nostre vite, dunque tutte grandi problematiche del nostro tempo, che potremmo analizzare come attenti sociologi, forse freddamente; eppure la storia degli hikikomori non è solo questo: è una storia fatta di fragilità, di insoddisfazioni private, di drammi tutti unici e di una straordinaria tenerezza e sensibilità dinanzi al mondo freddo e impetuoso.
Hikikomori sono coloro che, ritiratisi dal turbine, decidono di stare per le proprie, senza outburst vendicativi nei confronti del mondo cane circondante, che anzi se li meriterebbe. Qui quietamente vivono una loro vita, che, se pure sembra godibile (sebbene talvolta non sia che l’unica altra possibilità al fuori), si manifesta in un’atrofizzazione graduale, un seppellirsi nella propria camera; un perdere ogni slancio non solo politico e sociale verso il mondo, ma meramente umano.
Se non è la morte di un individuo, è la morte dell’ uomo come animale sociale; ed è la sconfitta di una società che non ha saputo offrire un nido sicuro ai suoi cittadini. Fenomeni come la dispersione scolastica e l’hikikomori sono fattualmente battaglie perse di un sistema scolastico obsoleto, di una schiatta di professori tutto tranne che pedagoghi; di un obbligo generazionale che ci presenta, esasperandoci, all’ambito mondo del lavoro.
Questo passaggio, dall’adolescenza alle responsabilità adulte, è una delle più gravi cause di hikikomori, in quanto consiste nella prova più ultima delle aspettative sociali e parentali, che si attendono un impiego decoroso, familiare e di carriera.
Oggi che i bisogni fisiologici, alla base della piramide di Maslow, sono soddisfatti più facilmente di quanto lo siano stati nella storia dei secoli, con l’apice della medicina e della ricerca, sembra invece che le persone inizino a morire per quei bisogni di autorealizzazione in cima alla piramide, che ci vengono imposti al di là delle nostre volontà e aspettative; queste ultime, invece, risultano soppresse: e questa differenza fra i nostri desideri e i nostri fallimenti, che siano questi in attività che davvero volevamo intraprendere o in attività che il fuori ci aveva spinto a intraprendere, questo scollamento ci fa disperare e voler nascondere in un buco.
Il Giappone è la patria degli otaku, dei NEET, degli hikikomori. Eppure, se questi individui, particolarmente ossessionati dai manga, dalle fanzine, videogiochi e blog online, furono inizialmente riconosciuti dalla società giapponese come dei parassiti, dei fannulloni, dei molestatori e dei pervertiti, col tempo la loro connotazione mutò fino a tramutarli in veri e propri eroi popolari, personaggi con cui il ragazzo medio potesse dialogare e in cui potesse almeno parzialmente ritrovarsi.
I termini otaku e weeb, che originariamente indicavano con una punta di disgusto uomini cresciuti che nutrivano croniche ossessioni per manga, anime, action figures e gadget vari, iniziarono a essere un punto di riferimento all’interno della comunità online dei fan degli anime, nonché all’interno dello stesso Giappone.
Si arrivò addirittura a libri (Densha Otoko) e manga e anime (Welcome to the NHK, Meteru no Kimochi), in cui gli hikikomori divennero non solo ritratti come veri e propri eroi, ma anche presentati con una spiccata umanità e con un’attenzione nuova, unita a una notevole auto-ironia, rispetto alle proprie fragilità e al proprio stato degradante.
Dunque anche in una società estremamente rigida e competitiva come quella giapponese, costellata dai casi di karoshi, e dalla vergogna dei ronin, le nuove generazioni hanno potuto veicolare una nuova sensibilità: segno che è ormai noto a tutti che gli hikikomori siano prodotto di una cultura delle aspettative tossiche che è universalmente esecrabile, e che quindi sia per loro perfettamente legittimo chiudere una porta, per presentare, anche nel loro silenzioso individualismo, una propria visione di mondo sempre più condivisa, il che ce li mostra, alla fine dei conti, non poi così tanto lungi dal barone di Rondò.